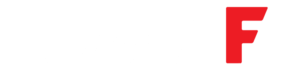C’era una volta John Galliano. E per fortuna c’è ancora, più vivo che mai, portato nuovamente al centro di quella scena che gli spetta di diritto grazie a un imprenditore illuminato – Renzo Rosso – e alla complicità di un brand storico – Maison Margiela -, che ha trovato finalmente il suo nuovo, folle autore. La favola ha il suo lieto fine. Ma non si esaurisce qui, perché dallo scorso mese di gennaio uno tsunami dall’alto coefficiente artistico si è abbattuto sulla settimana dell’alta moda di Parigi prendendo la forma di “Artisanal 2024”, lo show che, più di tutti, ha mostrato che cosa sia realmente una sfilata.
Il perfetto gusto per la provocazione di Galliano, maestro del dramma e del coup de théâtre, si è concretizzato – come già in passato in ognuna delle sue collezioni per Givenchy e per Dior – in uno spaccato di storia trasformato ad uso e consumo del suo genio irriverente, confermandolo magico burattinaio nell’orchestrare ispirazioni e spunti di un universo modaiolo a confronto del quale tutto il resto è, ovviamente, noia. Con le sue povere creature – dirette però dal regista Baz Luhrmann, portatrici sane di una sensualità grottesca e onirica, che si muovevano traballanti sotto il ponte parigino Alexander III, vestendo una collezione-capolavoro al limite del surrealismo, tra corsetti e succinti abiti Belle Époque -, lo stilista si è fatto testimone di un senso della moda capace di andare oltre l’urgenza ossessiva del descrivere, del commentare, del reagire al tempo presente. Facendo sognare. Regalando stupore. Disegnando una magia della quale fruire a piacimento per trovare requie dalle fatiche del reale. Mostrando, in una parola, l’esatta ragione d’essere della moda.
E la cosa non dovrebbe stupire più di tanto. John Galliano appartiene da sempre al gotha di quei creativi che, da soli, hanno stravolto il concetto di fashion show trasferendolo in uno spettacolo vero e proprio, corollario perfetto di un contenuto estetico da sogno. Il potere della moda, del resto, è tutto qui: un compendio sfaccettato e ricco, che ha portato, tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo millennio, lo stesso Galliano, Marc Jacobs, Karl Lagerfeld e Alexander McQueen a farsi mattatori assoluti di eventi su cui si è scritto e dei quali si è parlato fino alla stanchezza, e che hanno esaltato il potenziale performativo degli abiti – e dei corpi che quegli abiti indossavano – fino all’esasperazione, trasformando la passerella in un set pregno di significati, la cui potenza espressiva trascendeva l’estetica dei vestiti per mutarsi in statement, ideologia e bellezza, arte ed emozione, spettacolo allo stato puro. Dimentichi delle mere ragioni commerciali, questi artisti dell’effimero si sono dilettati con gli abiti e con la capacità percettiva degli spettatori, suscitando meraviglia e repulsione e stupore. Ma anche allegria.
Perché rileggere il reale attraverso le collezioni è, da sempre, il modo perfetto per trascenderne la matericità tessile provocando un’esperienza sensoriale profonda e indelebile, in grado di giocare con l’efferatezza stessa dell’essere umano. Storyteller d’eccezione di una moda-spettacolo, ma altresì custode di una forte e potente visione del mondo, Alexander McQueen è stato pioniere nel trasferire sulla passerella quel compendio di incubi e deliri di cui si ammantava il suo mondo, perso tra atmosfere cupe di matrice elisabettiana e immagini poco rassicuranti di un futuro distopico. Non mancava nulla: dalla fascinazione per la robotica, alle atmosfere esatte di un ospedale psichiatrico; dalle segrete della Conciergerie all’epoca dell’Ancien Régime, a maratone di ballo in salsa western, sconfinando tra ologrammi iconici e cavalli alati, in un caravanserraglio emotivamente indimenticabile.
Altrettanto fissi nella memoria sono i fotogrammi dei fashion show nei quali lo sfrontato ragazzo di New York arrivato alla corte francese di Louis Vuitton ha concentrato il suo talento scanzonato e ironico, ammaestrandolo con le imprescindibili sfumature di un lusso con pedigree che non aspettava altro che di essere investito da un’adrenalina stilistica senza precedenti. Marc Jacobs ha portato in passerella top model vestite da infermiere con look ispirati all’opera di Richard Prince accanto ad apparizioni oniriche in groppa a cavalli di una giostra immaginifica; e, ancora, paladine di bellezza tra i vagoni dell’Orient Express, insieme ad ammiccanti ragazzacce tra i chiaroscuri ispirati a “Il Portiere di Notte”, in una miscellanea di esibizioni gioiose e accattivanti, che gli hanno permesso di esprimersi liberamente, travolgendo codici e facilonerie. E Karl Lagerfeld, alla direzione creativa di Chanel, ha fatto anche di più. Le sue sfilate hanno messo concretamente in luce lo Zeitgeist di cui la moda era portavoce, esaltandone il contenuto fiabesco e immaginativo. Come cornice prediletta, il parigino Grand Palais, che nelle sue mani è diventato un malleabile contenitore pronto ad accogliere visioni sempre diverse: baite innevate, spiagge lambite dalle onde, affollati supermercati, manifestazioni chiassose. La potenza della creatività del Kaiser era in grado di dare vita ai set più attesi della fashion week francese.
E poi cos’è successo? Che cosa ha fatto sì che il circo della moda si involvesse seguendo le fila di un percorso che, nel tempo, è passato dalle prime sfilate riservate a privilegiati ‘happy few’ negli atelier delle maison, alle passerelle semi nazional-popolari, fino ai sopraccitati show spettacolari sfociati, nel periodo post pandemico, in eventi essenziali fruibili ‘urbi et orbi’ grazie ai social network? Che cosa è andato perso, tale da ridurre la narrazione fashion a sterile racconto, scarnificato al punto da vivere di soli messaggi commerciali? Commerciale è forse l’aggettivo più corretto per esemplificare il computo dei passaggi che hanno trasferito la fame di immaginari e di bellezza in semplici sfilate, capaci sì di flirtare con l’incanto, ma di confinarlo alle “sole” collezioni mostrate sulla catwalk. In nome di un’idea di moda concreta, a tratti ripetitiva, che appare impotente nell’esorcizzare le difficoltà del momento storico attuale e che si limita a disegnare vestiti – portabili, portabilissimi – immergendoli in un contesto neutro che non fa sognare, ma che non provoca nemmeno timori. Una moda che, in risposta ai marosi degli scenari contemporanei, disegna un’apparenza di normalità e di sicurezza – non è forse da questa esigenza che Sabato De Sarno, new entry da Gucci, ha concentrato la sua visione al grido de “Il cappotto è qualcosa che mi fa sentire al sicuro”? – e fa serenamente a meno del fattore sogno per navigare in una tranquilla placidità. Per lo meno fino a quando John Galliano non suona forte la campanella richiamando tutti all’ordine, o meglio, a quel suo disordine creativo chiassoso ed esuberante, per raccontare una moda che va oltre gli abiti e che diventa storia tout court. Di vita. Di stile. Di quella couture ancora in grado di fare sognare e di restare, così, immortale.